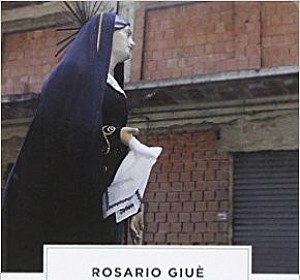Don Puglisi e don Diana sono un esempio, non l’unico, certo, di uno stile diverso, capace di far emergere il significato “umanizzante” che il messaggio cristiano può assumere per i singoli e per la comunità civile, in nome di un Dio che ha scelto di essere anche vero uomo. E questo è tanto più appropriato in quanto la mafia non si riduce a singoli atti criminosi, ma, come viene giustamente sottolineato in queste pagine, costituisce una vera e propria «struttura di peccato» (p.149), da cui la vita di uomini e donne è tragicamente condizionata. Da qui la sincera passione con cui l’autore ne sottolinea l’incompatibilità con la fede e l’inaccettabilità da parte della comunità cristiana. I limiti di questa coraggiosa denunzia sono, però, due. Il primo (a nostro avviso il più grave) è di avere identificato nel rapporto col fenomeno della mafia il nodo cruciale dello “scollamento” tra pastorale e vita reale, ignorando o minimizzando tutti gli altri problemi che rendono oggi problematico il rapporto tra Vangelo e cultura e società. Il secondo è di avere caricato in modo esclusivo la responsabilità di questo ‘scollamento’ sulle pronunzie ufficiali dell’episcopato, scambiando un momento importante, ma non certo isolabile dal contesto della pastorale, per l’unico rilevante.
Un terzo aspetto discutibile del libro di Giuè, ma collegato strettamente al secondo, potrebbe essere individuato nell’atteggiamento ipercritico con cui quelle pronunzie vengono analizzate.
Oggi anche papa Francesco preferisce situare il discorso sui cosiddetti «valori non negoziabili» in un più ampio orizzonte salvifico. Ma non ci sembra possibile bollare la prospettiva ecclesiale sui temi della famiglia e della bioetica come «visione integralista e statica della verità» (ivi). Tanto meno di considerare l’enunciazione chiara dei princìpi su questi temi come un attentato alla laicità dello Stato (p.126). È purtroppo vero che la nostra pastorale oggi non riesce a incidere in modo decisivo sulla società, producendone una ‘conversione’ culturale benefica già sul piano semplicemente umano. Su questo punto Giuè ha ragione. Ma ciò non riguarda solo e innanzitutto la mentalità mafiosa. Certamente, essa, e anche in questo concordiamo con l’autore, ha ormai da tempo una portata nazionale e implicazioni esistenziali profonde. Ma, proprio per questo, non va isolata e contrapposta a un ben più ampio quadro veritativo e valoriale, la cui crisi si manifesta in molti modi.
C’è da chiedersi se una simile concretezza operativa possa venire dalla Conferenza episcopale italiana (la prima ‘imputata’ di questa pretesa omissione) o non debba, sulla scorta delle enunciazioni di principio, essere ricercata attraverso un rinnovamento dello stile quotidiano dell’evangelizzazione a livello locale, sul territorio. Che è quello che ha reso così pericoloso per la mafia l’impegno pastorale di don Puglisi. Un cenno, infine, all’ipersensibilità che l’autore mostra, nell’esame dei documenti, nei confronti della lettera. Come quando sottolinea con sospetto il fatto che a volte vi si parli di ‘criminalità organizzata’, invece che di ‘mafia’. O che in alcuni testi, pur denunziando un atto di violenza, non si sia fatto espressamente il nome delle singole vittime. Francamente, la sostanza dei problemi sembra sia altrove. E precisamente nei contenuti di una pastorale spesso ancora legata a quel dualismo tra sacro e profano che autorizza i mafiosi (ma non solo loro!) a considerarsi ‘buoni cristiani’ perché rispettosi di forme religiose tradizionali, senza mai essere costretti dallo stile della comunità ecclesiale a scegliere tra comportamenti conformi al Vangelo e comportamenti che ne sono la negazione. È questa, in fondo, l’esigenza, in sé pienamente condivisibile, che sta al fondo del libro di Giuè, anche se il modo in cui viene sviluppata finisce per disperderla spesso su falsi bersagli.