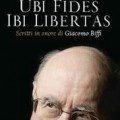«Travestiti da pastori / o scorta volontaria dei re Magi / andiamo a Betlemme cianciando d’amore e di pace, / comunque nascondendo / sotto il mantello di ogni evenienza / un kalashnikov ben oliato». Sono versi piuttosto forti questi di un poeta appartato e ormai dimenticato, Giovanni Angelo Abbo, morto nel 1994. È curioso che la poesia è intitolata Natale 1987: in realtà, essa è ancor più attuale oggi, quando si parla di pace, eppure il mercato delle armi e le potenze politiche continuano a immettere i loro prodotti di guerra e di morte nelle varie nazioni.
Intanto il Natale tradizionale continua le sue coreografi�e pubblicitarie, i suoi apparati di luci e di regali, i suoi rituali commerciali. Intendiamoci: anche questo aspetto esteriore, in un tempo in cui si tende a cancellare ogni simbolo o memoria religiosa, ha un signi�ficato. Tuttavia, con i flussi ininterrotti e spesso tragici dei rifugiati, con le bombe di Aleppo e le tende dei terremotati non ci si può, da cristiani, impunemente abbandonare a gadget e panettoni, a luminarie e capitoni.
È per questo che abbiamo pensato di riproporre una scena natalizia evangelica nota ma di solito marginalizzata, quella di Cristo profugo in Egitto con i suoi genitori. Anni fa il pittore Renato Guttuso in una delle cappelle del Sacro Monte di Varese ha voluto raf�figurare Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù proprio come una famiglia di profughi del Vicino Oriente, impauriti, costretti ad abbandonare la loro casa errando nel deserto. Contrariamente alla gioiosa retorica natalizia, il racconto evangelico della nascita e infanzia di Cristo nei 48 versetti dei primi due capitoli del Vangelo di Matteo è, infatti, tutto striato di sofferenze: nasce in una grotta-stalla, è deposto non in una culla ma in una mangiatoia, si affaccia subito l’incubo di Erode, è trasferito in terra straniera per non fi�nire sotto la spada che elimina i neonati di Betlemme in quella che sarà nota come “la strage degli innocenti”.
Già l’ombra della croce si proietta, dunque, sui primi giorni della sua vita ed è signifi�cativo che la scuola artistica russa di Novgorod nelle icone della Natività di Cristo, a partire dal XV secolo, abbia raffi�gurato il Bambino avvolto in fasce funerarie e deposto in una culla a forma di sepolcro.
Ci fermeremo ora solo sull’evento della fuga in Egitto che è così narrato da Matteo: «Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto, e resta là fi�nché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase �fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall’Egitto ho chiamato mio figlio» (2,13-15).
Queste scarne parole evangeliche sono più preoccupate di offrire un’interpretazione teologica di quella fuga che non di documentarne le componenti storiche (è questa una caratteristica generale dei Vangeli e in particolare dei cosiddetti “Vangeli dell’infanzia di Gesù” presenti nei capitoli 1-2 di Matteo e di Luca). Infatti, con la citazione �finale desunta dal profeta Osea (11, 1) – «Dall’Egitto ho chiamato mio fi�glio» – si vuole alludere a quell’evento capitale della storia dell’Israele biblico che fu l’esodo dall’oppressione faraonica: Cristo ne ripercorre emblematicamente le tappe, incarnando sofferenza e salvezza, oppressione e liberazione. E alla �fine risuonerà in Egitto l’appello rivolto a Giuseppe, il padre legale di Gesù, per il ritorno verso la Terrasanta: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nel paese di Israele perché sono morti coloro che volevano la vita del bambino» (2, 20).
Sullo sfondo storico c’è la �figura del famoso re Erode, la cui biogra�fia può essere ricostruita con lo storico giudaico Giuseppe Flavio: essa fu scandita da grandi successi politici, ma anche da un implacabile pugno di ferro nel sedare ogni minimo accenno di opposizione. Macrobio, storico romano del V secolo, attribuirà all’imperatore Augusto un detto riguardante Erode: presso costui erano più fortunati i porci (non commestibili per gli Ebrei) di quanto lo fossero i �figli (in greco le due parole hanno un suono affi�ne), perché Erode aveva anche liquidato fi�gli, mogli e parenti, sospettati di tramare alle sue spalle. L’Egitto, confinante con la Palestina, costituiva, dunque, un’ideale terra di esilio per i perseguitati.
Matteo, con la sobrietà propria dei Vangeli canonici, non aggiunge nulla a quel ritratto essenziale di una famigliola che avanza verso l’ignoto: tutto il racconto sopra citato, nell’originale greco, è composto solo di una settantina di parole. È la stessa vicenda dei rifugiati che approdano alle nostre coste: non lasceranno traccia nella storia e i loro nomi, le loro attese, le loro paure si dissolveranno nel silenzio o, peggio, in quella tomba d’acqua che è il Mediterraneo. Come è noto, sono stati invece i Vangeli apocrifi�, con le loro ricostruzioni fantasiose a immaginare un viaggio trionfale di Gesù, Maria e Giuseppe in quella terra straniera.
Palme che si piegano per offrire datteri, belve che si accucciano, polle d’acqua che sprizzano dalle sabbie del deserto, idoli dei templi egiziani che cadono a terra davanti al passaggio di Gesù, briganti che si convertono: questa è la sceneggiatura mitica che, per pagine e pagine, prosegue a svelare meraviglie in quegli scritti apocri�. Essi avranno il merito di alimentare l’arte nei secoli e di dare origine alla comunità cristiana d’Egitto, che ancora oggi è presente in modo signi�cativo in quella terra. Si tratta dei copti, un termine che è la deformazione del greco Aiguptos, “Egitto”, perché essi erano indigeni di quel Paese prima dell’arrivo nel VII secolo degli arabi musulmani.
Chi ha visitato un po’ più a lungo l’Egitto sa che il cuore antico della città del Cairo è popolato di chiese copte (Santa Barbara, San Sergio, San Giorgio, Maria Vergine, La Chiesa “Sospesa”), spesso legate simbolicamente al passaggio della Sacra Famiglia. Nella cripta di una di esse, quella dedicata ai soldati martiri Sergio e Daco, la tradizione popolare vuole che Gesù, Maria e Giuseppe trascorressero un inverno, abbandonandola da luglio a settembre quando il Nilo allagava quella grotta nel tempo della piena.
Memorie, comunque, ben lontane da quelle scarne parole dell’evangelista Matteo che presenta gli inizi della vita terrena del Signore all’insegna della povertà, della fuga, della sofferenza. La liturgia di questo Natale, con la voce instancabile di papa Francesco, si trasforma allora in un appello a ritrovare tra i volti spauriti dei profughi che vediamo scorrere sugli schermi televisivi anche quello del piccolo Gesù e quelli angosciati di Maria e Giuseppe, e a stendere le nostre mani per incrociarle con le loro.
Fonte: FamigliaCristiana.it