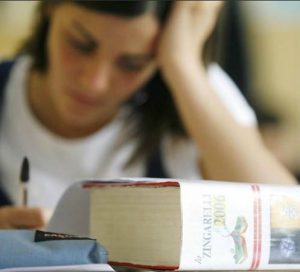Salvare l’italiano sembra essere ormai un’emergenza non più rimandabile. Ma ogni iniziativa deve fare i conti con giovani diversi da ieri.
Rilanciare l’insegnamento dell’italiano sembra essere ormai un’emergenza non più rimandabile. A documentarlo, anche la recente iniziativa del Miur che, dopo l’estate, ha dato vita ad un pool di esperti con il compito specifico di arginare le carenze linguistiche di studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
L’allarme, va detto, era già scattato nel febbraio scorso quando 600 tra accademici, linguisti, storici e filosofi, in un documento inviato al governo, avevano denunciato come “molti studenti scrivessero male” e avevano pertanto richiesto un intervento urgente. A guidare la task force recentemente istituita, il linguista Luca Serianni, incaricato dal ministero di raccogliere la sfida.
Intervenire in un dibattito di questa portata non è cosa facile vista anche la complessità del tema. E tuttavia i miei quarant’anni di insegnamento dell’italiano nella scuola media, mi consentono di offrire forse un piccolo contributo, facendo appello soprattutto all’esperienza.
C’è una considerazione che ritengo imprescindibile e che mi trova in linea con quanto affermato da Anna Angelucci in una lettera aperta a Luca Serianni: si tratta — sintetizzo — di riportare i nostri studenti dal mondo virtuale in cui sono immersi, al mondo reale, quello cioè che li circonda.
Che cosa ha voluto dire, nei miei anni di insegnamento, lavorare con i ragazzi assumendo questa ipotesi?
Tenterò di documentarlo con qualche esempio.
Se nel 2009 la normativa non prevedeva ancora una “didattica inclusiva”, a Sesto San Giovanni (mia cattedra di titolarità) la percentuale di alunni stranieri andava progressivamente crescendo e al problema della diffusa incompetenza linguistica degli italiani, si aggiungeva la presenza nelle classi di numerosi ragazzi che ignoravano quasi del tutto la nostra lingua o ne rifiutavano addirittura l’apprendimento.
Puntare sulla scrittura significava offrire a tutti l’opportunità di lavorare, ciascuno — s’intende — partendo dal proprio livello di competenza. Proposi così un percorso autobiografico con l’obiettivo arduo di mettere insieme un libro in cui ciascuno studente potesse contribuire con un segmento della propria esperienza.
Desideravo insomma chiamarli — cito Serianni — “ad interpretare ciò che li circonda nel mondo” oltre che “allenarli a riflettere su quello che scrivono” perché in primo piano ci fosse finalmente la realtà.
Far emergere qualcosa che li incuriosisse o li interessasse, sembrava tuttavia un’impresa disperata! Eppure, come dimenticare l’entusiasmo dei loro primi successi insieme all’emozione di sentire letti da me, in classe, i loro testi: la storia del nome che portavano e il perché di quella scelta, una vacanza coi nonni, il dolore di strappi legati a laceranti partenze, la morte di una persona cara, la storia di una nascita, il rapporto con gli adulti, la vita in famiglia.
All’inizio di ogni capitolo avevo scelto un brano d’autore, pertinente all’argomento, perché lo utilizzassero come modello. Facevo notare che gli elenchi erano banditi da quelle pagine mentre le descrizioni illuminavano particolari inediti che accendevano il testo di singolare ricchezza. Anche le loro descrizioni dovevano allora, dal bianco e nero, diventare a colori in un paziente lavoro di riscrittura condotto insieme: ogni nome andava affiancato da un aggettivo che fosse adeguato; guai all’uso di “bello”, “brutto”, “grande”, “piccolo”: troppo generici e spenti per essere ospitati nei loro testi! E allora, via con le gare di lessico, vocabolario alla mano, per trovare nuove strategie che evitassero ripetizioni, cacofonie, ridondanze. Mai esercizi di grammatica fine a sé stessi! La ricerca lessicale andava messa in cantiere sulla loro produzione scritta costruendo magazzini di parole — sostantivi, aggettivi e verbi — da utilizzare alla bisogna. I temi cominciavano a diventare così l’occasione per la verifica di un percorso e il supporto che mi chiedevano non era più: “cosa posso scrivere”, ma: “come posso scrivere quello che ho da dire”. La pagina bianca insomma non faceva più così paura, ma rappresentava una sfida con cui misurarsi.
Esperienze analoghe le feci con la messa a punto di un epistolario: dopo aver intercettato nell’antologia lettere e diari sul modello di Calvino o di Anna Frank, proposi una corrispondenza di classe, settimanale, su argomenti liberi purché partissero dalla loro esperienza. Prima di allora, quei ragazzi non avevano mai ricevuto una lettera né mai l’avevano spedita. Così, per consegnarla al compagno cui era indirizzata, la infilavano nella busta e arrivavano persino a disegnarci il francobollo.
Cresciuti nel virtuale, erano affamati di realtà!
Nei tre doposcuola che ora seguo, non mi trovo più ad impattare un’intera classe, ma ragazzi singoli e per lo più stranieri. Poterli introdurre alla scrittura continua ad essere un compito affascinante.
Un esempio per tutti: mi compare di recente una ragazza; seconda superiore; deve correggere e ultimare un tema assegnatole dalla prof. durante la prima settimana di scuola; la richiesta è stilare il resoconto delle vacanze estive. Ha elaborato un testo veramente brutto! Proviamo a metterci mano insieme. Suggerisco qualche modifica evitando di sostituirmi. Alla mia proposta di utilizzare “angusta” anziché “piccola” per definire una camera del suo soggiorno estivo, la ragazza rimane in silenzio. Le chiedo conto della perplessità; mi risponde che teme l’insegnante: le dirà che il tema non è farina del suo sacco! E non può essere — dico io — che tu abbia inserito un nuovo aggettivo nel tuo vocabolario? Non te la sentiresti di dirglielo? Risposta: “Non mi crederebbe mai!”
“Voliamo più in alto, insieme ai nostri studenti” sosteneva, nella lettera aperta a Serianni, la professoressa Angelucci. Non è forse questa l’audacia che ci manca? Nelle parole di Sant’Agostino, “fu guardato e allora vide”, si nasconde un suggerimento prezioso anche per iniziare un ragazzo all’apprendimento della lingua: è dal di dentro di un rapporto infatti che può accendersi in lui l’interesse per quelle segrete potenzialità che l’adulto ha il compito di e-ducere, tirare fuori, per essere finalmente un “reale” educatore.
Fonte: Giulia Sponza | IlSussidiario.it