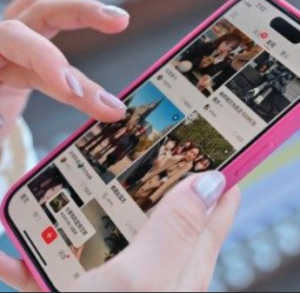Che l’immersione massiccia nel mondo virtuale stia provocando guasti, più che benefici, allo sviluppo psicologico, cognitivo e comportamentale degli adolescenti è un fatto riscontrabile nell’esperienza, oltre che un dato riconosciuto ormai in una vastissima parte della letteratura medico-scientifica, e non. Alcuni, come Jonathan Haidt, docente alla New York University, arrivano a formalizzare le principali conseguenze che si sono generate sulla prima generazione — la “Gen Z” — nata e cresciuta con lo smartphone in mano: privazione del sonno, disturbi dell’attenzione, proliferazione di stati d’ansia e depressione, paura del confronto sociale. Una serie di problemi alla salute mentale esplosi in particolare a partire dagli anni 2010-2015. Ma la lista sarebbe lunga, oltre che in continua evoluzione.
«La questione, al fondo, è lo spostamento della vita dei ragazzi dal reale al virtuale», spiega in una conversazione con «L’Osservatore Romano» Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Milano. «Invece — aggiunge — occorre essere chiari: virtuale non è reale. Quindi non è neanche ciò che si fa in sé, il problema: è il “dove” a contare. In questi anni siamo stati tutti vittime, e molti, spesso, protagonisti, di una narrativa secondo la quale i device elettronici sono solo strumenti: basterebbe quindi imparare ad usarli bene per ricavarne dei vantaggi. In realtà non è così: i device sono oggi “luoghi” che fermano la vita nel reale per farla entrare nel virtuale». E lo smartphone, di fatto, è un’estensione del corpo.
Una drammatica dimostrazione di questa confusione è percepibile, per esempio, nel caso delle “challenge” — le sfide — che nascono nel mondo digitale, ma le cui conseguenze, talvolta dolorose e tragiche, vengono pagate nella vita reale. A quel punto «vieni messo di fronte a un principio di realtà di cui il digitale non ti aveva detto nulla». Nell’utilizzo degli smartphone, pertanto, ci sono pericoli «sia di natura quantitativa — quanto tempo viene speso in una giornata per interagire con uno schermo, impedendo ai ragazzi di stare con gli amici nella vita reale — che qualitativa: perché un conto è interagire con una community di studio su un aspetto o una tematica specifica, che ci arricchisce; un altro è passare le ore a scrollare Tik Tok o a giocare online a un videogioco».
Tra tecno-entusiasti e tecno-scettici, il rischio, dall’altro lato, è quello di schierarsi in maniera acritica. «Ma l’obiettivo, sottolinea Pellai, non è mettere in discussione il processo tecnologico tout court, che ha portato enormi progressi in diversi settori, a cominciare da quello della salute e della medicina. Fare un uso strumentale del digitale è certo positivo. Il punto è che mentre si stanno facendo cose buone intervengono tanti potenziali “Lucignoli” — notifiche, app, richiami — che portano in un mondo “altro” rispetto a quello che ci si era prefissati di frequentare». Resistere a queste attrazioni sembra impossibile. «È il “dilemma di Pinocchio”, e non è un caso che in molti Paesi stiano crescendo le scuole “smartphone-free”, che non sono totalmente prive di digitale, ma che non permettono agli studenti di avere sempre a disposizione i device».
Molti studiosi, però, tra i primi Luciano Floridi, sostengono che ormai non sia più ragionevole distinguere tra online e offline, ma che nel mondo iperconnesso di oggi si debba parlare solo di esperienza “onlife”. Purtroppo, però, sostiene Pellai, in questo modo «abbiamo danneggiato la vita degli adolescenti». Quando a partire dalla nascita di iPhone 4, con la fotocamera frontale, «abbiamo avuto nelle mani non più un cellulare ma uno smartphone, pur uscendo nel mondo ci siamo trovati immersi contemporaneamente nella vita digitale. E questo non ha portato alcun vantaggio. Ci ha fatto diventare multitasking ma ci ha allontanato dal principio di realtà, alterando per giunta molti funzionamenti della nostra mente». Pertanto, quello che dobbiamo promuovere, soprattutto per i giovani, è l’offline, perché è lì che essi acquisiscono abilità e competenze che formeranno il loro cervello e saranno utili per la vita, e che non acquisiranno mai con il virtuale». È proprio nella fase della pre-adolescenza e dell’adolescenza, alle quali Pellai ha dedicato bestseller come L’età dello tsunami e Tutto troppo presto, che il cervello è in una condizione di vulnerabilità, funzionando essenzialmente come un muscolo che andrebbe allenato «alle esperienze e alle relazioni della vita reale». È il tempo in cui si costruiscono le reti neuronali.
Ma l’allenamento richiede tempi lunghi e fatica, che l’era della gratificazione istantanea non consente più. La necessità di provare subito piacere è alimentata a dismisura da device e algoritmi dei social media, in grado di attivare la dopamina, un neuromediatore chimico «che ci muove verso tutto ciò che è immediatamente piacevole e gratificante: veniamo ancorati a quello stimolo col rischio di finire nella dipendenza e di annullare la capacità di tollerare fatica, frustrazione, dolore, sofferenza. Abbiamo strutture neurologiche adatte a sopportare la scarsità, ma viviamo affogati nella sovrabbondanza di stimoli dopaminergici, senza che il cervello si sia evoluto per funzionare in questo mondo».
Sembrerebbe non esserci via di uscita. In questa era «bisogna darsi regole e limiti chiari. E non aderire alla narrazione per cui lo smartphone è solo uno strumento. Di fronte a una “sostanza” che dà dipendenza, la capacità di auto-gestione non esiste: ci vuole qualcuno, l’adulto, che deve essere in grado di conoscere il piano di regolazione. Possibilmente in un’alleanza con le famiglie e tra le famiglie, che a un certo livello non può non coinvolgere anche agenzie educative e istituzioni, visto che ormai parliamo di problemi di salute pubblica», conclude.
Fonte: Alberto Pellai | Osservatoreromano.va